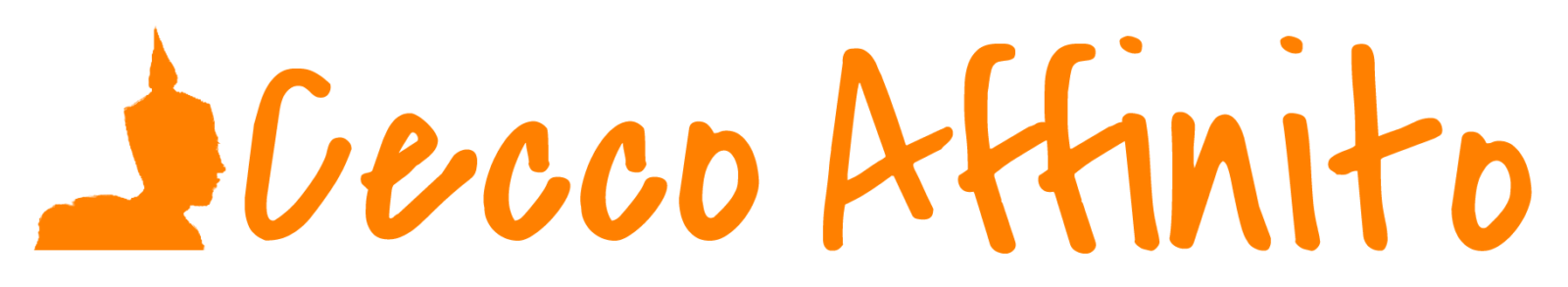Galileo Galilei: l’uomo che cambiò la concezione di scienza
Galileo Galilei è stato un matematico, fisico e astronomo italiano, nato a Pisa in una famiglia abbastanza colta. L’educazione che riceve è prettamente umanistica. Si iscrive a medicina per poi cambiare gli studi e passare a matematica.
Si trasferisce a Padova perchè trova una cattedra ben meglio pagata rispetto a Pisa e perchè poi la libertà di espressione in Veneto è superiore rispetto a tutti gli altri stati della penisola italica. Qui conoscerà varie figure in particolare Paolo Sarpi (colui che ha scritto l’Istoria del Concilio Tridentino un libro suddiviso in due volumi che racconta degli intrighi politici del concilio); pur essendo credente e frate, per via del suo libro, è stato messo all’indice perché secondo il sant’uffizio troppo antipapale.
Scoperte
A Padova compie le sue più grandi scoperte e pubblica i suoi libri più famosi.
Perfeziona il cannocchiale olandese cambiando semplicemente le lenti, grazie a quest’ultimo scoprì: i satelliti di giove, le fasi di venere e l’anello di saturno.
Scritti
Pubblica il Sidereus Nuncius e altre opere in cui conferma in modo implicito la teoria eliocentrica di copernico. La comunità di gesuiti e ecclesiastici inizia a guardare con malocchio Galileo. Fatto sta che il Sidereus Nuncius ha un riscontro mediatico enorme e acquisisce molta notorietà nella penisola in particolare a Firenze: lì riceve molte onorificenze dal duca.
Galileo ci ha donato un epistolario sia privato e sia pubblico oppure “Lettere Copernicane“, queste ultime scritte tra 1613-5 in cui sostiene la divisione tra scienza e fede. Il San’t Uffizio condanna il contenuto delle lettere e dichiara eretico lo scienziato di Pisa nel 1616.
Il Saggiatore
Galileo non si ferma e continua con le sue ricerche e pubblica quasi subito dopo il Saggiatore, un libro che critica la posizione di Orazio Grassi in in Libra astronomica ac philosophica sull’apparizione delle comete. Il Saggiatore ha una natura antiaristotelica e antidogmatica fondato sull’idea di eliminare l’Ipse Dixit cioè si richiama l’autorità di Aristotele come incontrastabile.
Galileo, dopotutto, rimane sempre cristiano ma con un certo disprezzo verso la curia.
Dialogo sopra i due massimi sistemi
L’ultima opera da citare è il Dialogo sopra i due massimi sistemi. L’opera è tristemente conosciuta come la fine del periodo felice di Galileo. Nel 1623 Urbano VIII (Matteo Barberini), amico di Galileo, diventa papa e nel 1630 approva la bozza del libro. Quando Galileo pubblica il libro, subisce un periodo di carcere a Roma e un carcere perpetuo a Siene e poi a Arcetri. Nel paesello di Arcetri viene accudito dalla figlia per via dei suoi problemi alla vista. Quando sua figlia muore rimane solo, riceve però visite da parte di Hobbes e Milton. Grazie alla dettatura Galileo pubblica i suoi due ultimi lavori Discorsi e dimostrazioni matematiche sopra due nuove scienze (grazie a questo libro vengono gettate le basi della macchina razionale moderna) e Sul candore lunare.
Struttura del Dialogo sopra i due massimi sistemi
L’opera è un trattato scientifico sotto forma di dialogo tra due fazioni: quella copernicana sostenuta da Filippo Salviati e Francesco Sagredo, invece quella tolemaica difesa da Simplicio.
L’opera è suddivisa in quattro giornate in cui si discute di diversi temi: la prima giornata l’argomento è il rapporto tra terra e gli astri, poi si sussegue l’autorità di aristotele, il problema delle maree e infine nell’ultima giornata si affronta il tema del moto orbitale della terra intorno al Sole.
Si ispira all’Ariosto come ideale di scrittura. L’ironia, il giudizio tagliente, la lucida argomentazione, la ricerca di un effetto sorpresa, l’uso di paragoni e l’efficacia persuasiva sono i fattori che hanno reso grande quest’opera e che ha ispirato vari autori come Leopardi e Calvino.
Galileo non è quindi solo uno scienziato ma anche un protagonista attivo della letteratura italiana. Grazie a lui la letteratura e la matematica possono avere un punto di incontro.
🗨️ Presentazione 🗨️
Galileo Galilei_Incontro tra letteratura e scienza_Francesco_Affinito_4A
articolo_numero_ventisei