
Il paradosso della libertà
Introduzione
Nell’immaginario comune, la libertà è vista con un significato materialistico, cioè viene tradotta in chiave giuridico-economica con esempi quali la libertà economica, nel lavoro e così via.
La definizione oggettiva del termine “libertà”, invece, parafrasando, indica una contrapposizione allo stato di schiavitù o di prigionia.
Può essere intesa solamente con queste definizioni?
La libertà spirituale e logica
Prendiamo come esempio la libertà di opinione. Questo presuppone che ogni individuo possa usare il suo più grande talento: il pensiero.
L’Illuminismo è il periodo storico che mette in risalto la libertà espressiva degli uomini; lo stesso Kant lo definisce, in poche parole, come una volontà delle persone di influenzare o di farsi influenzare, data una società che permette ciò.
Quella spirituale, di conseguenza, dovrebbe sottostare alla libertà logica, poiché il mezzo con cui dovrebbe essere praticata è sempre la mente; quindi, sarebbe più consono intenderla come sottocategoria. Al contrario, essa viene praticata attraverso l’utilizzo del cuore. Per questa ragione, è meglio concepirla come una categoria a sé stante. In ogni caso, c’è un’altra definizione di libertà, legata ad una possibilità di scelta.
La libertà politica
La libertà politica risulta difficile da classificare, perché esistono varie persone che la interpretano come fosse una religione o una serie di dogmi.
Facciamo un passo indietro: la politica ha come obiettivo di risolvere i problemi della collettività, che siano legati all’ambiente interno o esterno.
Si parla, in questo caso, di una libertà molto più pragmatica e platonica.
Parlando proprio del celebre filosofo Platone, egli stesso si concentra sulla figura del politico-filosofo che, secondo la sua visione, sarebbe il più portato a governare, trascurando i demagoghi e i populisti i quali vogliono creare un buco nero governativo e statale composto da retrogradismo e pochezza intellettuale. Un esempio tangibile attuale è senza ombra di dubbio il massimo esponente della ormai ex Lega Nord: Matteo Salvini. Una prova di ciò è la proposta di legge, del 12 aprile del 2022, che la Lega ha avviato per l’abolizione del “business” delle madri surrogate nel territorio nazionale.
A prescindere da quello che si pensi sull’argomento, il quale è molto delicato, già si percepisce l’obsolescènza di Salvini quando si focalizza sulla quantità di denaro con una superficialità sopra le righe. Il suo discorso, inoltre, non si regge in piedi perché privo di radici, sia filosofiche sia, soprattutto, politiche.
Come riporta un articolo di Wired la politica dovrebbe consistere nel “considerare il diritto come uno strumento per regolare e risolvere dei problemi, e non una frusta punitiva“, cosa che lo stesso Matteo non comprende.
Quindi, la libertà, in particolar modo nella politica, dovrebbe essere finalizzata a risolvere le problematiche di qualsiasi comunità.
Nazionalismo
Il nazionalismo è uno dei tanti discendenti della politica, già trattata in precedenza.
Esso nasce nell’epoca della rivoluzione francese con J.J. Rousseau che, in quegli anni di tumulto, dato il crollo della monarchia francese, possedeva una voglia di unione nazionale condivisa da altri compatrioti.
Il nazionalismo, che ha molto a che fare con la libertà, ci ha portato a una riflessione.
Riprendendo la teoria filosofica di Thomas Hobbes, l’uomo allo stato di natura (condizione pre-politica), avendo come caratteristica principale l’egoismo, e grazie alla possibilità di compiere ogni tipo di azione (libertà infinita), andava a creare situazioni di conflitto con il prossimo, per la sempre presente voglia di predominare. Di conseguenza, non avendo limiti come la legge, egli toglieva, ingiustamente, libertà ad altri. La stessa cosa si applica al nazionalismo, il quale si inserisce, principalmente, nel contesto dell’ottocento e della prima metà del novecento.
Per riassumere ciò che è stato appena scritto, la libertà è stata la causa principale dei conflitti più violenti nella storia dell’umanità; inevitabilmente, si contrappone con il concetto espresso all’inizio dell’articolo.
L’altra causa è data dalle privazioni in senso materiale e morale: un esempio è fornito dalla Germania pre-nazista, derubata delle proprie risorse economiche e della propria dignità come popolo. La mancanza dei due fattori suscitò un sentimento di rivalsa, promosso dal suo più celebre dittatore.
In conclusione, pensiamo che la libertà non sia da intendere solamente nel suo senso positivo; anzi,la componente negativa legata al termine risulta superiore. E ora, abbiamo risposto alla domanda?
Comments
Leave a reply
Devi essere connesso per inviare un commento.
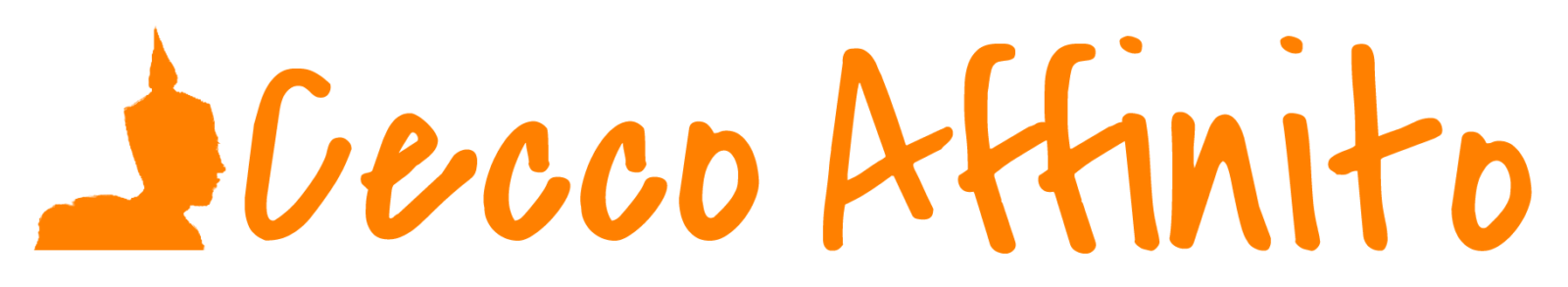


[…] Filosofia come strumento […]